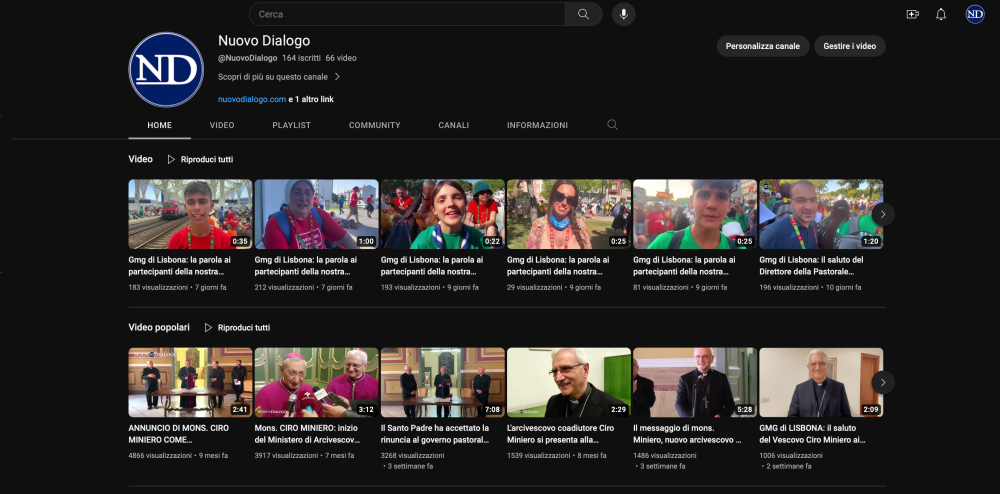Tacciano le armi: un grido nel deserto dal mondo della cultura

È stata l’unica italiana presente a un festival storico. Alla 26esima edizione del “Ditët e Naimit”. Un’occasione, la manifestazione andata in scena in Macedonia e Kosovo, che è servita ad esportare il talento della poeta e drammaturga tarantina, e nel contempo a ribadire la necessità del dialogo tra nazioni e popoli: Mara Venuto è naturalmente una donna di pace. Lo spirito di pace ha albergato nella recente manifestazione. Mentre la guerra continua, infuria in Ucraina.
Tacciano le armi
Cosa ne pensa lei sulla questione più dibattuta? “La mia posizione è simile a quella di tanti cattolici, proposta e portata avanti da papa Francesco sin dall’inizio del conflitto: l’invito a far tacere le armi e a riaprire i negoziati. Questa posizione, intesa come grido nel deserto, è molto minoritaria oggi”. “In Italia ci sono persone non favorevoli alla guerra, per ragioni egoistiche – spiega meglio la signora Venuto – per le ripercussioni importanti che ci sono state sull’economia”. In realtà il cessate il fuoco dovrebbe essere motivato dal sentimento di empatia o compassione verso la popolazione colpita.
L’invito è a guardare oltre: “Lo spargimento di sangue, le distruzioni, in un Paese che era già povero, di fatto condanna alla povertà intere generazioni”. Il guaio è che la volontà di pace sembra mancare anche dalla parte ucraina. MV ricorda il concerto per la pace che ha presentato il mese scorso ad Ostuni: “C’erano giovani musiciste ucraine residenti in Italia, alle quali ho chiesto se sperassero in una risoluzione del conflitto. La loro risposta è stata: noi non speriamo nella fine: noi vinceremo, schiacceremo la Russia”.

La missione della cultura,
l’esempio di Mara Venuto
Tornando all’esperienza del Festival “la realtà trovata in Macedonia e in Kosovo presenta analogie con quella di Ucraina e Donbass: si tratta di territori abitati da popolazioni diverse dal punto di vista etnico, linguistico e religioso, in contrasto le une con le altre”. Ecco la presenza salvifica della poesia. Che chiama a raccolta i suoi interpreti da tutto il mondo, anche dalle zone di conflitto, per unire. “Un tentativo riuscito, che ci dà anche una prospettiva, su quanto potrebbe accadere: ci fa comprendere che se c’è un obiettivo comune, la pace, contro l’inferno in terra della guerra, i popoli dovrebbero cercare di dialogare e riunirsi”.
La cultura in generale ci insegna che “non può esserci la fine delle ostilità senza un compromesso”. “Tutti devono rinunciare a qualcosa, altrimenti manca la base per negoziare”, aggiunge l’autrice della raccolta La lingua della città (Delta 3 Edizioni) ricordando che al festival c’erano poeti dalla Turchia e dagli Stati Uniti, un poeta proveniente dal Pakistan (“altra polveriera”), da Paesi prevalentemente ostili. “L’intento di tutti era quello di dialogare, di aprirsi, di ascoltarsi anche in lingue differenti. Non si comprende spesso quasi nulla ma si può entrare in un certo spirito”.