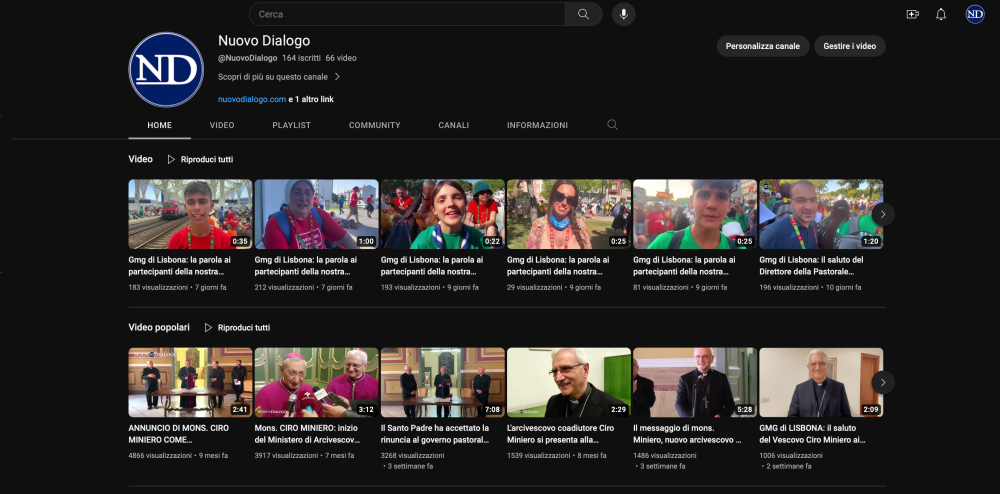Il 2025 sarà l’anno della svolta?

Mentre cala il sipario su un 2024 di sangue, con i recenti bombardamenti sulla capitale dell’Ucraina il giorno di Natale e la mattanza nella Striscia di Gaza che prosegue senza ostacoli e che ha portato alla morte di una neonata proprio la notte di Natale, ci si interroga sul futuro: l’insicurezza è diventata la questione prevalente di questo tempo. La si percepisce nella quotidianità, nelle relazioni interpersonali, nei rapporti sociali, nelle crisi del mondo del lavoro, nei processi di trasformazione dell’economia. La cornice di tale interdipendenza culturale, economica e sociale sembra essere sempre più incerta. Fino a non molti anni fa, sembrava che essere cittadini, essere portatori di diritti e di doveri verso gli altri, stesse dentro una cornice ampia e aperta, nella quale poi potevano stare le diverse identità, individuali, di nascita, di ambiente, di provenienza. Le tante guerre in atto stanno rompendo la cornice di interdipendente consapevolezza di essere cittadini del mondo. Forse tutto ciò sta in un qualche rapporto con la crescente insicurezza che si vive quando si vede il mondo attraverso le notizie che giungono dalla rete, dalla televisione o dai quotidiani. Succede, così, che si finisce per chiudersi a riccio nelle case o nelle parrocchie, perché, là fuori, c’è il buio, l’incerto, l’insicuro. Così, continuando, ci si affida alla nazione se in questo sporco mondo c’è il disordine, chiedendole protezione: da chi vorrebbe violare i confini e portare lo scompiglio nelle strade, nelle piazze e nelle università. Da chi può costituire, alla fine, una minaccia alla tranquillità di starsene in casa al caldo, mentre laggiù i missili seminano distruzione e morti. Succede, così, che si finisce per slittare verso un sentimento nazionalista, un insieme di credenze che darebbe una identità più forte. Già, perché l’identità è forza, in un mondo in cui tutti cercano di difendere la propria particolare posizione di potere. Ecco quindi, quella cornice ampia e aperta, quel sogno di un mondo multiculturale, multirazziale, multietnico, multilingue di un tempo appare parecchio lontano. I simboli del vecchio ordine appaiono fragili: l’Onu è sempre più evanescente; l’Ue non ha autorevolezza politica e stenta ancora a parlare con una sola voce; gli Usa vogliono diventare grandi ma non sanno ancora se ci riusciranno; tutto ciò che è ancora denominato Occidente sembra sempre più scolorito nei suoi contorni e incerto nell’azione. Dall’altra parte del mondo c’è un gran scalpitare di potenze che spintonano per avere più calore e più luce di prima sul proprio terrazzino: la Cina, l’India, la Russia e diverse altre medie potenze regionali. C’è chi parla di “nuovo ordine mondiale”, pensando che l’Occidente dovrebbe fare un passo di lato rispetto agli stati emergenti. La “non-guerra” che il mondo dal 1945 al 2022 ha vissuto ha fatto dimenticare, alle opinioni pubbliche, ma anche alle politiche nazionali che gli stati calibrano sempre i loro rapporti secondo il principio della “ragion di stato”. E che, dunque, per principio, gli stati non sono buoni, ma aggressivi per loro natura, se non c’è un potere superiore che regoli i loro rapporti. All’improvviso l’UE è diventata il ventre molle su cui si scaricano guerre e migrazioni dal sud del mondo, l’Europa si è scoperta fragile perché la minaccia russa è forte e la protezione americana non è più sicura e con Trump lo sarà ancor meno. Tutto ciò dovrebbe indirizzare verso una maggiore intesa, spingere verso una maggiore compattezza, verso un governo europeo capace di agire, anche con una propria autonomia e con una propria politica estera, e di pattuire direttamente con la Russia le condizioni di un sistema di sicurezza europea. Questo scenario ha finito per far crescere il tasso di insicurezza degli europei, perché non ci sono più punti di riferimento stabili e riconosciuti come tali, in termini di valori e principi radicati in istituzioni. È necessario un diverso discorso legittimante che compatti l’Ue attorno a principi e valori comuni, che occorre restare sempre compatti, per proteggere l’unità già creata e la pace di questi ottant’anni, perché è l’unità che disarma gli stati. Ma la effettiva grande sfida di domani è lontana dall’Europa. Il nuovo fronte – per adesso solamente manifatturiero e commerciale – è fra Usa e Cina. Questa è la vera battaglia che gli Usa di Trump si apprestano a fronteggiare a colpi di sfide commerciali e di dazi, mentre la miccia di Taiwan è sempre accesa. Ecco questo lo scenario del prossimo anno, un anno che porterà davvero numerosi cambiamenti. In quale direzione dipende parecchio dai protagonisti internazionali, a incominciare da Trump. Il 2025 potrebbe rappresentare un tornante della storia e un momento decisivo per sciogliere molti dei nodi globali che si sono aggrovigliati in questi anni: la speranza è che diventi un capitolo importante della geopolitica e delle questioni internazionali. L’unica via possibile transita attraverso una maggiore cooperazione internazionale e il superamento degli interessi di breve termine in favore di una visione globale di stabilità e di sicurezza.
VISITA IL MENÙ DEL GIUBILEO