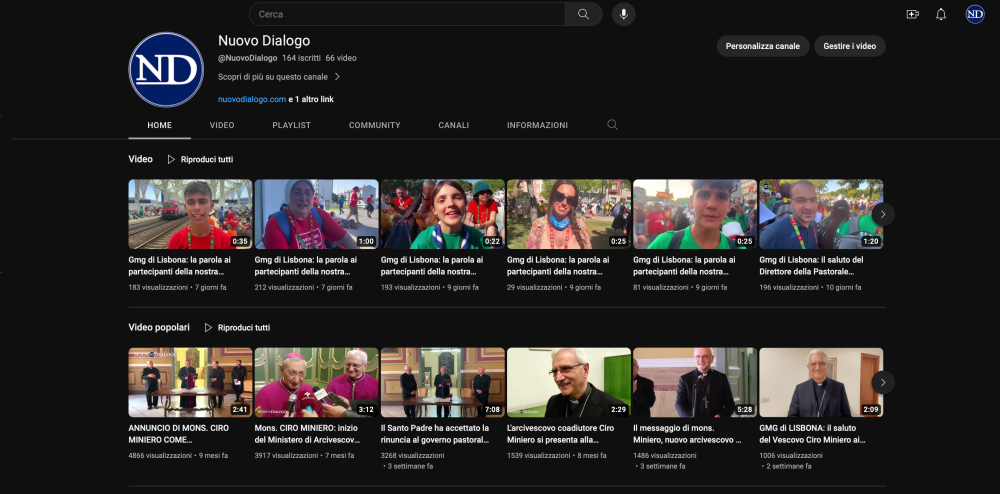Guardava oltre, con altri occhi

Anni che hanno modificato tutto: il Vaticano, la Santa Sede e, più di tutto, la Chiesa. E, ancor più, il mondo. Jorge Mario Bergoglio è stato prima di tutto la guida universale della Chiesa ma anche un leader politico, diametralmente e culturalmente antitetico ai suoi predecessori, anche se diversamente potente nella sua profetica battaglia contro la terza guerra mondiale guerreggiata a pezzi. In un mondo che è sempre favorevole a suddividere e a catalogare tutto e tutti, anche gli uomini della Chiesa, – destra o sinistra, noi o loro, conservatori o riformisti –, è stato amato e contrastato. Ma, in ogni caso, è stato un politico nel senso più alto e più nobile, un uomo di estese vedute e di grandi orizzonti, capace di imprimere alla storia svolte categoriche e traiettorie precise. Una vera guida, prima di tutto. Se ci si ricorda com’era la Chiesa prima del papato di Papa Francesco, bisognare citare il periodo del Vatileaks, degli scandali all’ombra del Cupolone, documenti riservati rubati dalla scrivania di Papa Ratzinger e buttati in piazza. E le lotte di potere, gli scandali della pedofilia nel clero che affioravano ogni giorno in tutta la loro drammaticità, le trame, gli intrighi e la scollatura con l’opinione pubblica. Quel 13 marzo 2013 un uomo, un prete, un autentico cristiano, salì alla Cattedra di San Pietro. Non che i suoi predecessori non fossero tali. Sul momento, il “buonasera” detto dalla Loggia delle Benedizioni, quella sera di marzo, suonò come un singolare passaggio di consegne: un uomo normale, un uomo comune diventava Papa. Un uomo che andava dall’ottico per farsi sostituire le lenti agli occhiali, che si recava in un negozio di ortopedia per acquistare delle nuove calzature, che entrava in un negozio di dischi per comperare un cd, che telefonava agli amici, che decideva di risiedere nella foresteria della Città del Vaticano invece che nella dimora papale del Palazzo Apostolico, che pranzava e cenava nella sala da pranzo di Casa Santa Marta, come tutti gli altri ospiti. Il Papa che ha mutato, semplificandolo, il linguaggio e i gesti. “Bisogna restare normali” disse Francesco, in una delle prime interviste. E così rimase. Prendendosi anche le critiche di tanti, conservatori e non solo, che intravidero in questa umanizzazione del pontificato una desacralizzazione della carica di Vicario di Cristo. È stato prima di tutto la guida universale della Chiesa universale: avvolto e immerso nelle tante ferite di questo tempo, è stato capace di sintonizzarsi sull’anima, sui sentimenti e sulla frequenza d’onda di oltre un miliardo di cattolici che al Papa guardano, come un gregge guarda al pastore. Ma anche di tanti non cattolici, non cristiani, non credenti, non osservanti, di ebrei, di musulmani. Le sue aperture non sono state approvate da tutti. E per ciò che concerne le riforme – per quanto non sia riuscito a portare a compimento alcune importantissime – non si può non ricordare la sinodalità come stile di governo, la scelta di chiamare delle donne – suore e non – a dei posti cardine dei dicasteri, delle commissioni, delle accademie e delle congregazioni della Curia, la scelta di nominare cardinali di ogni angolo del mondo, sempre dentro una concezione precisa: portare il Vangelo di Gesù, non la forza della Chiesa. Come se non bastasse, questo Vicario di Cristo ha traslocato il baricentro del mondo nella Chiesa e nella visione geopolitica, insegnando a guardare con occhi diversi, a vedere il mondo con altri occhi, a rivolgere lo sguardo a ciò che sta “oltre”. Su alcune questioni, anticipatore e anche voce solitaria: anzitutto sui migranti, sulla scia di morte che le epocali emigrazioni stanno provocando oggi, non solamente nel Mediterraneo ma anche in altri contesti, si pensi all’America latina o alle popolazioni fuggite dall’Iraq in guerra o dalla Siria distrutta. Papa Francesco ha posto la Chiesa sulla prima linea. Accogliere, proteggere, promuovere e integrare: sono i quattro verbi che Bergoglio ha posto come lumi spirituali per una politica delle migrazioni e che adesso restano lì, ancora tutti da vagliare e attuare. Il monito pronunciato ad Assisi il giorno dopo la strage di Lampedusa ha segnato un crinale nel rivendicare da che parte sta la Chiesa: gli ultimi. E con Laudato si’ sulla cura della casa comune, la Chiesa è diventata la “motrice” di una coscientizzazione non ideologica ma realistica della spinosa emergenza ambientale. Coscienza che incomincia con il rispetto della persona umana e che reclama protezione della persona, dal suo concepimento alla sua morte naturale. Scontando, in questo caso sul fronte etico, la catalogazione di conservatore riguardo ai temi dell’aborto e dell’eutanasia che vengono respinti, inserendo tali atti di rispetto della natura umana in un perimetro più ampio, che prevede anche il rifiuto della pena di morte. C’è poi l’amicizia sociale, neologismo che Fratelli tutti ha posto come tassativo per non far scivolare il mondo nella guerra mondiale: amicizia sociale come ricerca costante di una possibilità di incontro piuttosto che lo scontro, la diplomazia invece che le armi, il negoziato al posto del pugno di forza. Su questi punti, come su altri, Francesco non ha convinto tutti: l’apertura ai migranti qualcuno l’ha vista come una resa all’immigrazionismo; sulla cura dell’ambiente qualcuno, anzitutto a destra, l’ha giudicato prono sull’ambientalismo come nuova religione; e, sul piano internazionale, la sua postura severa ha attirato delle critiche. È morto dopo aver celebrato la Pasqua di Resurrezione il Pontefice che ha dilatato i confini della Chiesa, che – allo stesso modo del cardinale Martini, gesuita anche lui – ha avuto un passo più veloce della Chiesa e che lascia l’eredità di concretizzare, ogni istante, le indicazioni dei suoi insegnamenti.
VISITA IL MENÙ DEL GIUBILEO