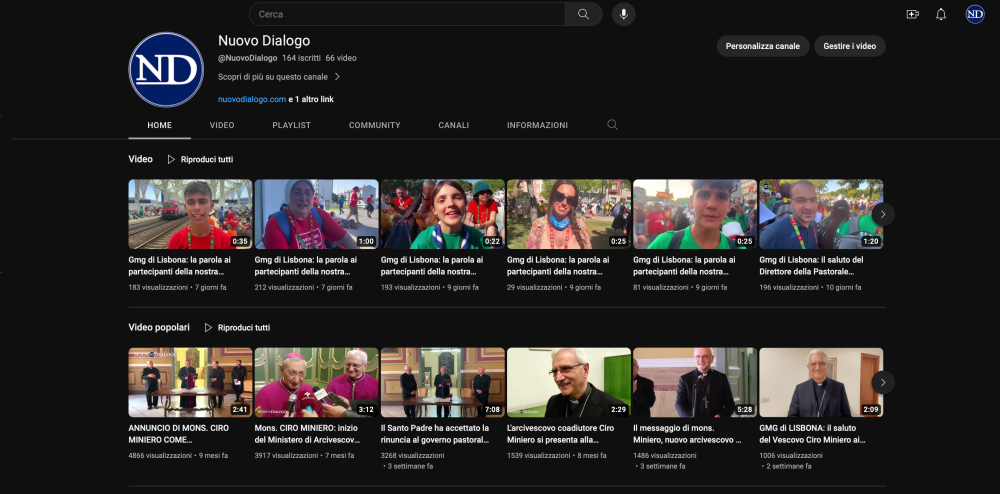San Cataldo: le diverse ricostruzione del rinvenimento del corpo in un libro di Lucio Pierri

Sarà presentato lunedì 5 maggio, alle 19,30, nel soccorpo nella Basilica cattedrale, dove venne rinvenuto il corpo del santo, il libro “San Cataldo tra storia e leggenda”. Scritto da Lucio Pierri e pubblicato dalle edizioni Scorpione, sarà presentato Piero Massafra, col coordinamento di monsignor Emanuele Ferro e i saluti l’arcivescovo Ciro Miniero. Il volume è il quarto della Collana di studi storici e archeologici degli Amici del Castello Aragonese di Taranto OdV.
Alla presentazione sarà presente l’autore, al quale abbiamo rivolto alcune domande sul lavoro, scaturito da una ricerca seguita al reperimento integrale del Sermo de inventione corpporis sancti Kataldi. Che è stato possibile attraverso il rinvenimento sul mercato antiquariale, della trascrizione che venne operata nel 1924 da Adolf Hofmeister, in occasione di un convegno organizzato dalla Biblioteca di Monaco.
Lo studio
Rinvenimento che, come abbiamo già anticipato nei giorni scorsi, sostanzia una seconda narrazione, più antica di quella che si vuole fondata sulla testimonianza del Berlingerio (XII/XIII sec.) in cui si riverisce della morte e del seppellimento a Taranto nella cappella di San Giovanni in Galilea, e del ritrovamento del corpo dopo diversi secoli da parte dell’arcivescovo Drogone nel rifacimento dalle fondamenta della chiesa. Il racconto contenuto nel Sermo risalirebbe, invece, a una testimonianza precedente, trascritta attorno al 1150. Vi si riferisce del ritrovamento del corpo di Cataldo in una chiesa rurale presso Taranto a opera di un monaco longobardo e la sua traslazione nella chiesa di San Biagio all’interno città, prima del trasferimento in cattedrale.
Abbiamo, quindi, chiesto a Lucio Pierri:
In che modo il reperimento integrale del Sermo de inventione corporis sancti Kataldi, ha sollecitato la sua attenzione sulla storia del santo patrono Cataldo?
Il Sermo de invenzione corporis sancti Katali è venuto, in realtà, dopo; la motivazione che mi ha spinto a ricercare le origini del culto di san Cataldo è stato il reperimento casuale sul mercato antiquariale di un vecchio Officium di San Cataldo datato 1710. Da qui la curiosità ad indagare, avevo comunque già letto quanto scritto dagli antichi e dagli storiografi moderni, e poi sono particolarmente legato alla chiesa di San Cataldo, ho conosciuto il Soccorpo prima dei restauri dello Schettini del 1951, si entrava allora da una porticina laterale, per terra vi erano ancora alcune ossa, e poi sono salito da una scala polverosa anche sul vecchio campanile normanno; mi portava mio nonno Egidio Baffi che era amico di monsignor Blandamura.
La novità del mio lavoro è data dal fatto, che con la diffusione di internet ho potuto avere accesso ai documenti originali, che nessuno di quelli che mi hanno preceduto aveva potuto consultare nella loro interezza. Il rinvenimento del Sermo è dovuto invece ad un colpo di fortuna, ho trovato in vendita il testo integrale, pubblicato in Germania nel 1924 negli gli atti di una conferenza organizzata dalla Biblioteca di Monaco. È il più antico documento su San Cataldo, firmato e datato da un monaco di nome Marinus del convento di San Severino a Napoli. Oggi conservato in una trascrizione del 1174 custodita nella biblioteca nazionale di Vienna.
Può aver avuto un ruolo decisivo la diatriba tra Normanni e Longobardi sulle origini del santo? La diversità delle fonti può avere un ruolo in questo senso?
Più che tra Normanni e Langobardi, penso che si tratti di conflitti tra la chiesa bizantina e i Normanni, nuovi venuti. Quando arrivarono i Normanni, fecero delle alleanze con il Langobardi contro il potere bizantino, la loro prima guida in Puglia fu Melo che era longobardo.
Poiché le fonti storiche nel caso di Cataldo come di tanti altri santi, sono comunque incerte, trattandosi di fatti accaduti molti secoli fa, si può pensare di unificare la tradizione in un’unica narrazione? Avrebbe un senso?
Si la cosa può essere tentata, partendo da un presupposto, la storia, quella documentata parte dalla sepoltura (seconda o terza) di San Cataldo nel Soccorpo, tutte le fonti sono concordi su questo. Prima di questo avvenimento abbiamo diverse narrazioni a volte discordanti. Possono essere individuate tre tradizioni, quella primitiva del Sermo che parla di San Cataldo come un antico vescovo venerato in una chiesa di campagna vicino la città di Taranto e da lì traslato prima a San Biagio e poi nel Duomo. Quella ufficiale della antica chiesa tarantina che ne nobilita l’origine facendolo nascere in Irlanda e attribuendogli diversi miracoli, tra i quali appena nato la resurrezione della madre morta di parto, il viaggio in Italia, la morte a Taranto e il successivo rinvenimento del corpo in cattedrale ad opera di Drogone. Vi è poi una tradizione “veneta” secondo la quale san Cataldo nasce e muore in Irlanda, senza una spiegazione di come il suo corpo possa essere arrivato a Taranto, con una rocambolesca invenzione di un autore del seicento, Lodovico Zacconi, che nel suo Catalogo dei santi, pubblicato a Venezia nel 1610, afferma che Drogone sia andato con una banda di armati a rubare il corpo in Irlanda.
Si, riunendo i vari tasselli, si può tentare di ricomporre il puzzle, ma devono essere trovati tutti i tasselli, gli anni cruciali sono quelli a cavallo di undicesimo e dodicesimo secolo, quando da Taranto si irradiano queste narrazioni, probabilmente attraverso cartigli che accompagnavano le donazioni delle sue reliquie. Il Capecelatro ricorda quelle in occasione della traslazione del 1346, ma certamente un’altra donazione deve essere avvenuta all’epoca dell’arcivescovo Gerardo nel 1151. A comporre il puzzle vi è inoltre un documento molto antico (ne ho potuto avere la foto solo pochi giorni fa), di poco posteriore a questa epoca, (la Biblioteca Ambrosiana che lo custodisce lo data scritto tra 1201 e 1209); sembra un documento originale proveniente da Taranto che farà molto discutere. Oltre ad una vita di San Cataldo, il cui testo sarà ripreso ed ampliato dagli autori veneti del secolo successivo, contiene anche la storia di un altro santo venerato in Taranto con una colorita descrizione della città.
Si intravedono collegamenti tra il culto tarantino testimoniato delle tradizioni orali e scritte con il culto professato in altre comunità? E altrove quali ricostruzioni prevalgono sulla sua vita?
Può darsi, il culto di san Cataldo ebbe una enorme diffusione proprio nel XII secolo in Italia, come ci informa Alberto Carducci, con propaggini in Sicilia, a Malta, in Terra Santa, a Costantinopoli, ed anche in Francia, come provato dalla documentazione archivistica ed archeologica. Una ricerca richiederebbe uno studio lungo e complesso, ma per quanto se ne sappia, dopo l’ufficializzazione del suo culto da parte della Chiesa di Roma nel 1580, sarebbe stato difficile produrre documenti contrastanti. San Cataldo è anche protettore di Corato in Puglia, dove si utilizzava nelle celebrazioni religiose lo stesso Officium tarantino, che nel 1681 venne ristampato, congiuntamente alla diocesi di Taranto, da una tipografia di Trani.