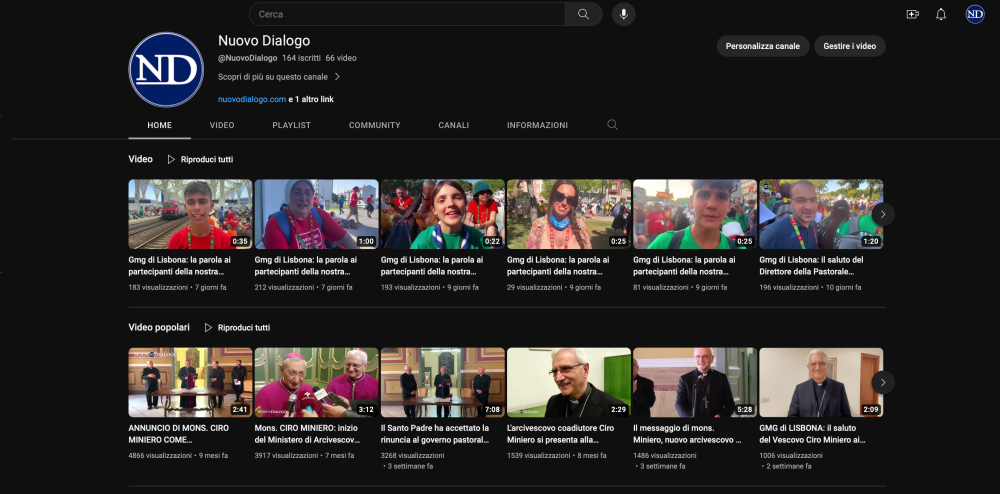La teologia dal Mediterraneo: approdi critici e nuove rotte verso il farsi dell’umano

La scorsa settimana, nel salone delle scuderie dell’episcopio di Taranto, si è tenuto un incontro organizzato dal Centro culturale dello sviluppo Lazzati, guidato dall’on. Domenico Amalfitano e dall’Istituto superiore di Scienze religiose di Taranto, diretto da don Francesco Nigro. All’incontro ha partecipato un folto pubblico che si è messo in ascolto e dialogo con il relatore principale don Vincenzo Di Pilato, teologo sistematico di Trani e membro del comitato per il Mediterraneo per la Facoltà teologica pugliese. L’incontro ha inteso offrire uno sguardo sul percorso inaugurato nel 2019 da papa Francesco a Napoli-Posillipo dove invitò le varie Facoltà teologiche del Mediterraneo a riflettere insieme sulla natura e missione che questo spazio geografico, culturale e storico poteva avere anche in ambito teologico.
In continuità con questo evento ‘fondatore’ il 23 settembre del 2023 il compianto papa Francesco così si esprimeva a Marsiglia, al congresso sul Mediterraneo: “Fratelli e sorelle, nell’odierno mare dei conflitti, siamo qui per valorizzare il contributo del Mediterraneo, perché torni a essere laboratorio di pace. Perché questa è la vocazione: essere luogo dove Paesi e realtà diverse si incontrino sulla base dell’umanità che tutti condividiamo, non delle ideologie che contrappongono. Sì, il Mediterraneo esprime un pensiero non uniforme e ideologico, ma poliedrico e aderente alla realtà; un pensiero vitale, aperto e conciliante: un pensiero comunitario, questa è la parola. Quanto ne abbiamo bisogno nel frangente attuale, dove nazionalismi antiquati e belligeranti vogliono far tramontare il sogno della comunità delle nazioni! Ma – ricordiamolo – con le armi si fa la guerra, non la pace, e con l’avidità di potere sempre si torna al passato, non si costruisce il futuro”.
Sono parole così attuali e vere per il contesto storico in cui viviamo. Cosa può significare pensare in chiave “mediterranea”, aprire il nostro orizzonte particolare dal nostro territorio verso il contesto vitale del Mediterraneo da cui siamo avvolti e inondati?
Il ‘Mare nostrum’, segno di vita, di traffici, di pesca, di viaggi, di civiltà, culture e religioni, è diventato, dice sempre il papa, anche ‘mare mortuum’ per tutte le vittime delle tratte e tutti coloro che fuggono da miseria e violenza per una speranza di bene nel futuro, spesso naufragata . Il vero nocciolo della questione sociale e culturale odierno non è tanto legato alla crescita di tanti problemi , ma alla decrescita della cura. Il pensiero cristiano ha come assi cartesiane la carità e la sapienza, ma il punto di convergenza è la cura. Curare non è assistenzialismo o paternalismo, ma la forma concreta dell’amore gratuito, è la voce del pensiero sapienziale che accompagna il credente. Un cristiano è sempre un pellegrino, un viandante, ma anche un guaritore ferito, una persona che sa offrire guarigione perché riconosce, accoglie ed integra le sue ferite e quelle altrui sperimentando che tutto questo è la sua storia di salvezza.
Quale pensiero teologico potrà sorgere in questa terra di incontri tra le differenze, o come le definiva don Tonino Bello, in questa convivialità delle differenze? È sempre il papa che così si esprimeva: “La sfida è anche quella di una teologia mediterranea – la teologia dev’essere radicata nella vita; una teologia da laboratorio non funziona –, che sviluppi un pensiero aderente al reale, “casa” dell’umano e non solo del dato tecnico, in grado di unire le generazioni legando memoria e futuro, e di promuovere con originalità il cammino ecumenico tra i cristiani e il dialogo tra credenti di religioni diverse. È bello avventurarsi in una ricerca filosofica e teologica che, attingendo alle fonti culturali mediterranee, restituisca speranza all’uomo, mistero di libertà bisognoso di Dio e dell’altro per dare senso alla propria esistenza. Ed è necessario pure riflettere sul mistero di Dio, che nessuno può pretendere di possedere o padroneggiare, e che anzi va sottratto ad ogni utilizzo violento e strumentale, consci che la confessione della sua grandezza presuppone in noi l’umiltà dei cercatori”.
Il contributo di don Vincenzo Di Pilato è stato quello di offrire uno sguardo sul processo di sviluppo di un pensiero mediterraneo, citando tanto nell’ambito laico Franco Cassano, ma non solo, quanto in ambito cattolico il magistero che da papa Leone XIII in poi ha promosso la cultura dell’incontro e dell’impegno sociale, coniugando riflessione teologica e attenzione al contesto socio-culturale.
Attraverso alcuni passaggi importanti il teologo tranese ha illustrato quella che è il ‘Manifesto per una teologia dal Mediterraneo’ prodotto e sottoscritto dalla maggioranza delle Facoltà teologiche cattoliche del Mediterraneo Si evince da questo testo la necessità di una teologica contestuale e narrativa, ossia un pensiero teologico non può essere astratto ma radicato nel territorio e nella cultura che vive. Pertanto si parla di teologia ‘dal’ Mediterraneo, come contesto di popoli e culture, nazionalità e fedi diversificate ma anche accomunate da non pochi elementi, come l’accoglienza, l’ascolto, il dialogo, la condivisione, la solidarietà. L’accento è posto in modo speciale sulla dimensione dell’ascolto di quanto emerge dai vari scenari di vita del Mediterraneo, soprattutto in questo frangente storico, ma anche dall’impegno a creare ponti con il dialogo, quale ‘parola tra’, ‘pensiero tra’, incontro nella complementarietà più che nella differenza conflittuale. L’intento è quello di valorizzare l’incontro con la vita, con la prassi e leggere nella religiosità popolare, tipica di questo bacino polietnico e religioso la capacità di mettere in dialogo anche saperi differenti, secondo quella trans-disciplinarietà che crea reti di saperi per un processo autentico di umanizzazione. L’incontro quindi si colloca come evento di promozione culturale sul territorio ionico e si spera vivamente che possa essere una esperienza ‘apripista’ per il futuro.