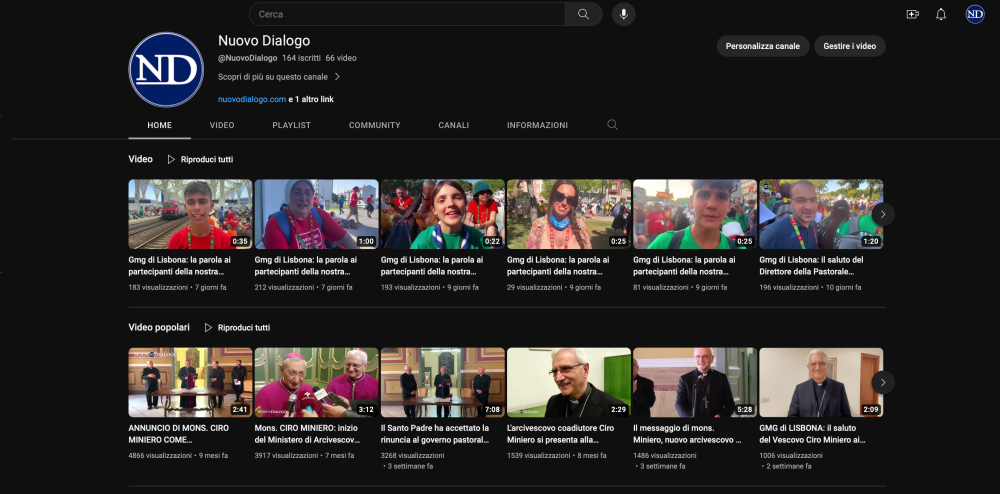Una sintonia fra la politica e gli affari

Strano, tutto strano, del tutto strano. A partire dal nome. Tregua? Pace? Armistizio? Cessate il fuoco? Ma che cosa è esattamente? È la sospensione momentanea della mattanza della popolazione civile della Striscia di Gaza da parte delle forze armate israeliane? Forse, ma, in sostanza, è una spartizione di risorse energetiche: il giacimento di gas, al largo della Striscia di Gaza, rivendicato dalla Palestina, che rientra nella zona economica esclusiva, vale a dire la porzione di mare, di quasi duecento miglia marine, sulla quale lo stato costiero ha diritti per lo sfruttamento e l’uso delle risorse naturali. Dunque, le concessioni rilasciate da Israele ad altri attori hanno seri profili di illegittimità internazionale: è una ruberia che, nel linguaggio comune, corrisponde a un furto. I titoli dei giornali e le dichiarazioni della politica mondiale hanno parlato e stanno tuttora parlando di tregua e di pace ma, sotto la facciata, c’è una posta in ballo che ha poco a che fare con il disinteresse. È potere, è denaro, è controllo. Lì, sotto il mare, è sepolta una verità difficile e coperta da anni di accordi presentati come tecnici, che hanno, in fondo, una sostanza economica. A Sharm el-Sheikh il governo di Trump ha schierato una delegazione formata da imprenditori e da businessmen anziché da diplomatici e da negoziatori: Steve Witkoff e Jared Kushner sono nello stesso tempo segnale politico e forza economica. Ciò che resta nascosto sono due giacimenti di gas naturale al largo della costa della Striscia di Gaza, scoperti nel settembre del 2000, a una distanza di ventidue miglia marine e a una profondità di oltre seicento metri, stimati fra trentaquattro e trentasei miliardi di metri cubi. Dal 2000, i due giacimenti sono al centro di dispute legali e politiche: le potenzialità energetiche, le ricadute fiscali e le leve geopolitiche. Chi controllerà quel campo avrà una leva economica e strategica su Gaza e sul Mediterraneo orientale? Ma ai tavoli della diplomazia siedono attori economici che vedono nella ricostruzione una opportunità di investimento. Tutto ciò rende la parola ricostruzione ambigua: è una promessa di aiuto oppure è un progetto di appropriazione delle risorse e di controllo del territorio? La Striscia di Gaza non è solo un teatro di guerra: nella ristrutturazione regionale in atto è un sito strategico sacrificabile per permettere il dispiegarsi di corridoi economici, di rotte energetiche e di reti digitali. La questione palestinese così è stata ridimensionata, facilitando progetti che richiedono territori gestibili. Se l’obiettivo è la costruzione di porti, di gasdotti e rotte commerciali, la stabilità che le grandi infrastrutture esigono deve tradursi in un ridisegno demografico e politico. Chi controlla cavi sottomarini e porti, controlla soprattutto i flussi di potere. Questa è la definitiva sintonia fra l’autorità pubblica e gli interessi privati, la politica e gli affari, il potere e il denaro. Due dimensioni mai del tutto separate, se non nelle teorie più astratte della politica e del diritto, ma che hanno raggiunto un punto di fusione totale nelle trattative di Sharm el-Sheikh. Nessuno personifica quella fusione meglio di Jared Kushner, il genero di Trump che, pur non avendo alcun ruolo ufficiale, è stato uno dei più attivi artefici dell’accordo. Sono sue le due intuizioni diplomatiche e affaristiche che hanno scandito il destino della Striscia di Gaza fin da prima del 7 ottobre del 2023: il progetto dello sfruttamento della zona come miniera immobiliare e, nel 2020, la approvazione degli accordi di Abramo, che avrebbero dovuto normalizzare i rapporti commerciali fra le monarchie del Golfo e Israele, rendendo innocue sia la questione palestinese sia le ambizioni egemoniche dell’Iran. Kushner non è solo un immobiliarista, ma è anche il fondatore e dirigente di una finanziaria privata, la Affinity Partners, il cui maggior azionista è il Fondo Pubblico di Investimento dell’Arabia Saudita, che ha oltre due miliardi di investimenti nell’azienda. In tale gioco delle parti, così intricato, è in sostanza impossibile distinguere l’interesse dei governi da quello dei privati. D’altra parte, è una sorpresa positiva che una sintonia così torbida possa perfino generare un accordo di pace, sia pure fragile e precario. Considerando la portata della mattanza degli ultimi anni, l’accordo è già tanto. È giusto essere felici per la fine della segregazione degli ostaggi israeliani, per la liberazione di quasi duemila imprigionati palestinesi e per la fine dei bombardamenti e della distruzione di quel che resta di Gaza. È un momento di gioia, celebrato nelle piazze, sia dagli israeliani sia dai palestinesi. Rimane, però, il fatto che è un accordo gonfio di non detti e di promesse, stipulato e concluso al di fuori di tutte le sedi delle organizzazioni internazionali, come le Nazioni Unite, e quel che è peggio, i palestinesi, come soggetto politico, o sono assenti o sono messi ai margini. La Striscia di Gaza, che l’esercito israeliano occuperà ancora per oltre la metà, si incammina verso il protettorato di affari a guida Trump, Gerusalemme est rimane capitale di Israele, la Cisgiordania resta occupata e ricolonizzata. Inquietante, nel piano Trump, è l’assenza di qualsiasi riferimento alla Cisgiordania e alle colonie, compreso il piano E1, che taglia il territorio in due e che è stato approvato dal governo israeliano il mese scorso. La domanda che resta in sospeso è quanto valga, in questo contesto, l’interesse delle persone che a Gaza ci abitano e che a Gaza hanno intenzione di restarci. Può darsi che i negoziati abbiano migliorato le prospettive. Lo speriamo tutti, ovviamente, ma non è consigliabile nutrire tante illusioni. Il dato di fatto è che la sintonia fra politica e affari, fra l’autorità pubblica e gli interessi privati, fra poteri e denari, si realizza molto spesso a scapito della società civile, comprimendone i diritti per facilitare i monopolisti del potere e della ricchezza.