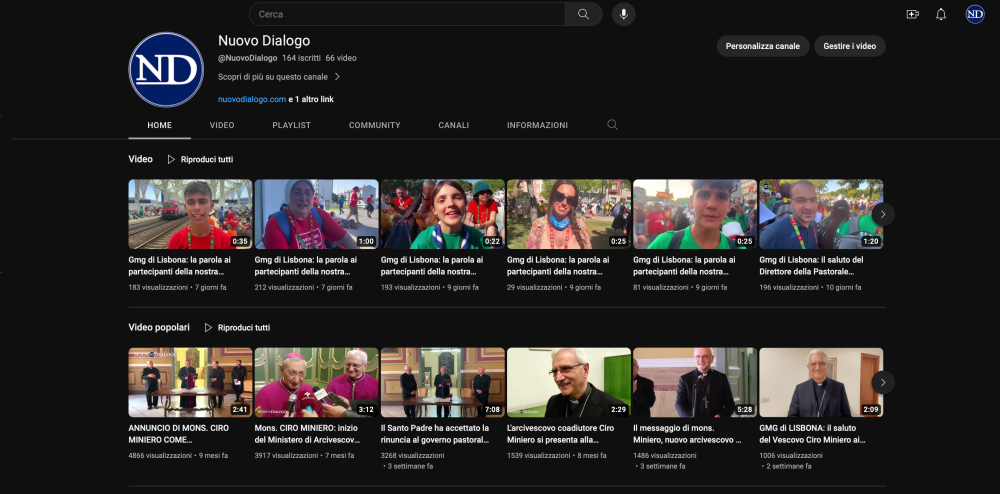Non sono eventi estremi, sono eventi possibili

Al cospetto di una calamità dell’ambiente, di un disastro della Terra o di una catastrofe della natura, è banale fare spallucce oppure dire che “così è la natura!”, come è altrettanto semplice lamentarsi delle autorità o, ancora peggio, gioire per l’insuccesso degli avversari sul campo politico. Dinanzi agli avvenimenti tragici, dinanzi ai morti, si dice sempre in queste circostanze “non è il caso di fare polemiche!”. Le alluvioni e le inondazioni che hanno colpito e stanno flagellando ancora adesso l’Emilia Romagna, però, non sono solo responsabilità delle piogge, dei rovesci, dei nubifragi o dei temporali. Una pioggia intensa, in brevissimo tempo, può anche verificarsi. Ma, ed è questa la prima domanda, si era pronti, si era preparati, si era organizzati? È sicuro: non si può prevenire tutto, le calamità sono così. Ma non lo sapevano i pubblici amministratori che gli alvei dei corsi d’acqua, di qualunque tipo, di qualsiasi lunghezza o portata o regime, devono essere sistematicamente ripuliti? E che gli scoli non funzionano se vengono tombati? Che l’acqua piovana filtra attraverso il terreno se le pendici dei monti sono state erose? Quanti, e quali, investimenti strutturali non sono stati fatti per tenere in ordine ruscelli, torrenti, fiumi e canali, per circoscrivere i danni causati da eventi eccezionali, in realtà, a questo punto, sempre più abituali e consueti? Anche se l’acqua si ritira rapidamente, le ferite determinate da una alluvione a un territorio richiedono molto tempo per rimarginarsi, anzitutto quelle subite dalle persone, sia nelle sue componenti materiali ed economiche, sia nell’anima e nel cuore della gente. L’alluvione del Polesine, del 1951, e quella di Salerno, del 1954, sono ancora presenti, non soltanto nella mente di chi le ha vissute, ma anche nel comune sentire di quelle popolazioni. Si potrebbe dire che sono i governi, di qualsiasi epoca e di qualsiasi colorazione politica, che dimenticano in fretta; ma se si continuano a costruire case negli alvei fluviali o in zone depresse nelle pianure alluvionali e i cittadini le acquistano, è segno che la cultura generale, in materia ambientale, non ha fatto tesoro delle esperienze passate. Sembra, in ogni caso, che il tempo per dimenticare sia terminato ed eventi chiamati estremi, in futuro, si ripresenteranno con sempre maggiore frequenza e con sempre più grande intensità. Chiamarli estremi non è altro che un rimedio per giustificare il fatto che non si è fatto niente, o troppo poco, per prevenirli o, quantomeno, per temperarne gli effetti: quegli eventi devono essere definiti possibili, anche se con piccole probabilità di manifestazione. E se un avvenimento può arrecare un grave danno, anche se è poco probabile che si verifichi proprio domani, non deve essere sottovalutato: chi prenderebbe un aereo già sapendo che vi è soltanto una eventualità su cento che possa cadere? Ma si finisce con il basare le scelte sugli scenari più probabili e non su quelli più catastrofici. Le pianure alluvionali costituiscono territori ottimali per gli insediamenti, le facilità di trasporto, le possibilità di coltivare e le disponibilità di acqua. Ci sarà una ragione per la quale si chiamano alluvionali? Per impedire l’esondazione dei fiumi, che depositando i sedimenti sul proprio letto, lo si innalza in continuazione, sono stati fabbricati degli argini che hanno portato il corso d’acqua a scorrere più in alto della propria pianura, mettendo, così, in estremo pericolo tutti quelli che vivono a un livello sottostante. La rottura degli argini del Po, nel 1951, non è stata sufficiente a far intuire che la sicurezza non si ottiene incanalando l’acqua verso il mare, che fra l’altro si sta innalzando, ma portando le popolazioni a vivere in zone rialzate. Se ciò non è possibile per le aree urbane, si dovranno prevedere estese superfici, più grandi delle odierne casse di espansione, da mandare sott’acqua per salvare le città, come è stato fatto in Olanda. Per chi ci viveva si fanno nuove case in aree protette, mentre per chi deve restare, queste si pongono su collinette artificiali che, all’occasione, diventano isolette. Si dice che il territorio italiano sia estremamente fragile, e anche questo termine andrebbe riguardato: è un territorio in una naturale evoluzione morfologica, forse più incalzante di altri. Siamo noi, esseri umani, che siamo fragili e deboli, perché spesso ci siamo insediati in quelle aree dove più rapida è questa evoluzione, come i versanti di rilievi costituiti da suolo predisposto alle erosioni, lungo i fiumi che cercano di cambiare il proprio corso e sulle coste, da sempre l’elemento più in movimento del territorio e ora colpite pure dall’innalzamento del livello del mare. Abbiamo disboscato le montagne, tagliato i versanti con vie di comunicazione senza tener conto dell’assetto geologico, strizzato i fiumi con argini, case, ponti e fabbriche, demolito le dune costiere per costruire villaggi turistici e passeggiate a mare. E anche nelle zone agricole, che ci illudiamo mantengano un minimo di naturalità, abbiamo fatto il possibile per aumentare il rischio idraulico. E quando, da lontano, si vedono quei paesaggi con chilometri e chilometri di serre con teli di plastica che impermeabilizzano il suolo, non pensiamo che fine farà l’acqua del prossimo temporale? Questi eventi possibili, con i cambiamenti del clima e il surriscaldamento globale, stanno diventando sempre più intensi e ricorrenti, e la nuova normalità a cui non vogliamo e a cui dobbiamo abituarci – siamo recidivi: abbiamo combattuto la nuova normalità post pandemia – è quella che, volenti o no, ci attende nel futuro.
VISITA IL MENÙ DEL GIUBILEO