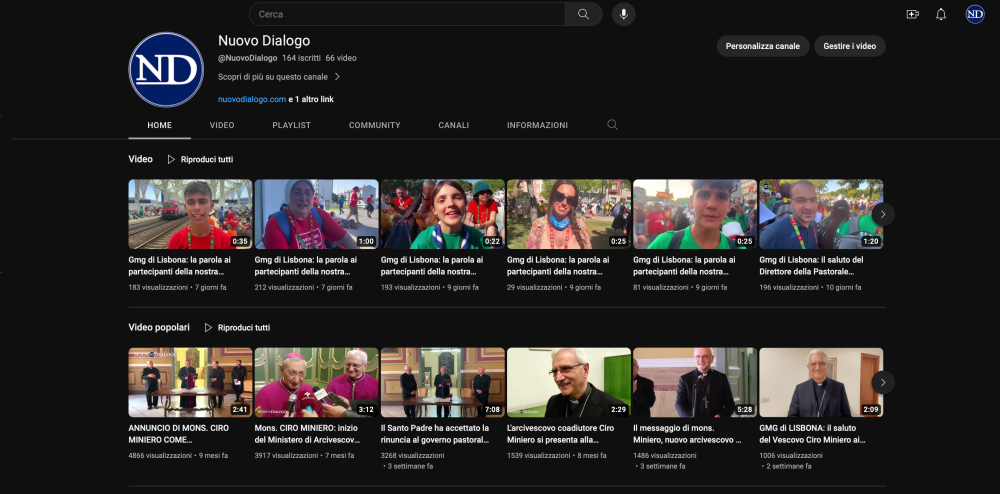San Cataldo: Un libro di Lucio Pierri cerca di mettere ordine nelle tradizioni

“San Cataldo tra storia e leggenda” è il titolo di un saggio scritto da Lucio Pierri e pubblicato dalle edizioni Scorpione, che sarà presentato il 5 maggio prossimo nella Basilica cattedrale da Piero Massafra. A coordinare sarà monsignor Emanuele Ferro, interverrà l’autore. Rivolgerà i saluti l’arcivescovo Ciro Miniero. Il volume è il quarto della Collana di studi storici e archeologici degli Amici del Castello Aragonese di Taranto OdV.
Siamo in grado di anticipare alcuni dei contenuti principali del volume di Pierri che alle tradizioni agiografiche e storiche riguardanti il santo patrono della città e della diocesi di Taranto si dedica da tempo. Una questione, quella della vicenda umana e storica di Cataldo, che da anni interessa e interroga studiosi e devoti, impegnati nel non semplice scopo di chiarire almeno le origini del santo vescovo. Come spesso accade per i santi vissuti molti secoli fa, le tradizioni sforano spesso nella leggenda, in carenza di documenti storici coevi esaurienti.
Così il saggio
Il saggio di Pierri si muove, infatti, sullo scivoloso tema della agiografia, tentando di discernere, attraverso un esame della documentazione antica, quanto si possa attribuire alla storia e quanto alla leggenda, circa la vita e le opere di san Cataldo. Le fonti sono varie, a volte coincidenti, a volte discordanti, ma tutte concordano su un dato centrale: il luogo di sepoltura del santo è nel soccorpo della cattedrale. Quello è un avvenimento certo e documentato che dà inizio alla storia, scandita con precisione nelle sue date, come sintetizzato dall’arcivescovo Capecelatro nell’Officium del 1787: Drogone nel 1071 rinviene il corpo e lo colloca sotto l’altare maggiore del Duomo. Rainaldo nel 1107 ne cura un migliore sepolcro. Gerardo nel 1151 fabbrica un mirabile sacello e vi ripone le reliquie custodite in una urna d’argento. Rogerio nel 1346 fonde l’urna di argento per ricavarne una statua a mezzo busto.
Sui dati storici “noti” l’autore non si dilunga, concentrandosi sulla ricerca delle narrazioni antiche, intessute dalla pietà popolare e dalla fede, sulla vita di san Cataldo, e come una di queste, recepita dalla chiesa e ufficializzate nella liturgia, abbia oscurato un’altra tradizione. Che era forse più antica e narrava in maniera diversa quelle vicende facendo di Cataldo un santo vescovo, sepolto in antiquo in una chiesa rurale posta fuori le mura della città di Taranto.
Le due narrazioni sono in apparenza inconciliabili. Le riassumiamo brevemente, così come riportate da Pierri.
La prima narrazione
La prima, fondata probabilmente dal Berlengerio nel XII/XIII secolo, recepita nei libri liturgici della Chiesa tarantina che si leggevano in occasione delle festività del santo, venne consolidata attraverso la pubblicazione nel 1555 dell’Officium beati Cataldi archiepiscopi Tarentini, de eius vita, miraculis, canonizatione ac translatione, ad opera Giovan Battista Argerius.
Quando quella liturgia nel 1580 venne portata a Roma dall’arcivescovo Brancaccio per ottenerne l’approvazione, non venne accettata in toto. Il Cardinale Sirleto, incaricato della revisione, ne tagliò la parte più poetica: la nascita a somiglianza di Cristo con l’apparizione della stella cometa, la profezia di una nascita prodigiosa e la resurrezione della madre morta di parto da parte del piccolo infante Cataldo.
Il ridimensionamento fu accettato ob torto collo dalla liturgia ufficiale, ma non dalla storiografia tarantina, che volle sempre mantenere viva la tradizione degli antichi libri, ad iniziare dal Giovan Giovine. Il quale, nove anni dopo, nel 1589, diede alle stampe il De antiquitate et varia tarentinorum fortuna, riportando integra la narrazione tradizionale. E così nei secoli successivi, sino a tutto il secolo XIX con la pubblicazione della Storia di Taranto del De Vincentiis nel 1887. Si dava per certa la nascita in Irlanda e l’episcopato irlandese, il viaggio in Terra santa, l’arrivo successivo a Taranto. Quindi: morte e seppellimento a Taranto nella cappella di San Giovanni in Galilea, ritrovamento del corpo dopo diversi secoli da parte dell’arcivescovo Drogone nel rifacimento dalle fondamenta della chiesa.
La seconda narrazione
Questa sistemazione del culto determinò l’abbandono di una memoria più antica che narrava in maniera diversa quelle vicende. Memoria contenuta in una misconosciuta “cronaca” scritta intorno al 1150, conservata in un codice custodito presso la Biblioteca nazionale di Austria. Di essa sino ad ora se ne era avuta solo qualche parziale e non sempre pertinente citazione. Se ne conservava però in maniera frammentaria il nucleo fondamentale. Che fa riferimento al ritrovamento del corpo di Cataldo in una chiesa rurale presso Taranto a opera di un monaco longobardo e la sua traslazione nella chiesa di San Biagio all’interno città, prima del trasferimento in cattedrale.
Il reperimento integrale di quella memoria, il Sermo de inventione corporis sancti Kataldi, è stato reso possibile attraverso il rinvenimento sul mercato antiquariale, della trascrizione che venne operata nel 1924 da Adolf Hofmeister in occasione di un convegno organizzato dalla Biblioteca di Monaco.
Nel suo saggio Lucio Pierri tenta di conciliare le due diverse narrazioni, e ipotizza come dalla prima si sia passati alla seconda, dal ritrovamento del corpo in una chiesa rurale da parte di un monaco di origine longobarda, a un ritrovamento in cattedrale a opera di un arcivescovo normanno.
In che modo? È quello che approfondiremo prossimamente interpellando lo stesso autore. Il quale, come vedremo, rimarca il ruolo avuto nell’accreditamento e diffusione delle tradizioni da parte delle diverse provenienze “geografiche” degli “attori” religiosi.
VISITA IL MENÙ DEL GIUBILEO