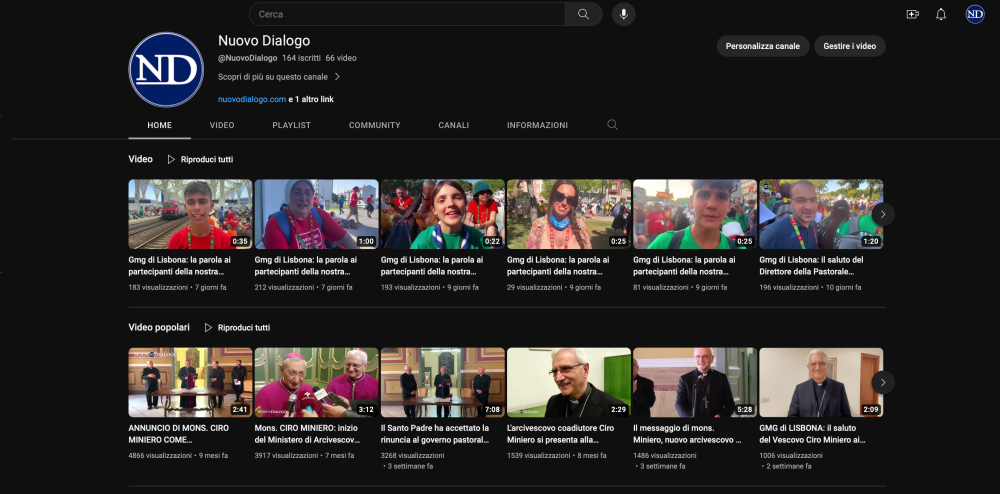Democrazia e libertà di stampa

È un richiamo imprescindibile e sarebbe grave non farlo, almeno una volta all’anno: rimarcare l’importanza della libertà di stampa vuol dire rilanciare il valore incommensurabile dell’informazione come bene pubblico, globale, da difendere dai condizionamenti di qualsiasi potere, sia esso politico, giudiziario, economico. Il 3 di maggio di ogni anno si festeggia la Giornata internazionale della libertà di stampa, istituita nel 1993 dall’Assemblea generale delle Nazioni unite in occasione dell’anniversario della Dichiarazione di Windhoek, documento comprendente il principio della libertà di espressione. È un momento di riflessione sullo stato di salute dei media nel mondo e sulla percezione della libertà di informazione che hanno i cittadini nella società multimediale in cui siamo tutti immersi. È un pungolo all’azione per governi, cittadini e operatori dell’informazione affinché vengano tutelati, rafforzati e promossi i principi fondamentali di una stampa indipendente e pluralista. È un diritto collettivo: riguarda la possibilità per ogni individuo di ricevere informazioni vere, di formarsi una opinione consapevole e di partecipare alla vita della comunità. Nell’epoca multimediale, caratterizzata da un evidente eccesso informativo, da algoritmi opachi, campagne di manipolazione e disinformazione, tutelare tale diritto è indispensabile. La libertà di stampa è un bene sacro, è l’ossigeno della democrazia e deve essere preservato attraverso un sistema integrato di protezioni legislative, cultura dei diritti e dei doveri, innovazione tecnologica. Da anni ormai Reporter sans frontieres e Freedom house monitorano la libertà di stampa. Ma di recente anche Liberties, una organizzazione che salvaguarda i diritti umani di tutte le persone che vivono nell’Unione europea, ha elaborato il Report sulla libertà di stampa 2025. Il documento mostra come in tutta l’Unione europea la libertà dei media si stia frantumando a causa di meccanismi di controllo verticistico dei flussi informativi e di una ostinata svalutazione della necessità di assicurare a ciascuno un libero accesso alle fonti giornalistiche in un contesto pluralista e garantista. Lo studio ha pure evidenziato come la libertà di espressione in Europa non sia sicura per tutti i giornalisti: appare compromessa e in grave pericolo nel caso dei giornalisti indipendenti o ritenuti lontani dalle forze governative. Da noi le principali preoccupazioni emergono dalla Rai, ritenuta molto vulnerabile alle interferenze politiche. Nel 2025 la Giornata della libertà di stampa è dedicata all’effetto che sta causando su tale diritto l’intelligenza artificiale. Le moderne tecnologie stanno mutando il giornalismo consentendo l’uso di nuovi strumenti in grado di aumentare la efficacia e la efficienza di tale professione. Proprio per perseguire tali obiettivi, diverse testate giornalistiche hanno iniziato a integrare all’interno dei propri processi l’IA. Però, questa innovazione non è esente da rischi, in primo luogo quello della disinformazione e della generazione di contenuti falsi, ossia l’ormai diffuso fenomeno di foto, di video e di audio creati grazie all’IA che, partendo da contenuti reali, sono capaci di modificare o ricreare, in modo estremamente realistico, le caratteristiche e i movimenti di un volto o di un corpo. Inoltre, apre anche diverse questioni etiche relative soprattutto alla privacy dei dati usati in fase di addestramento. Sebbene l’IA consenta di automatizzare tali processi, è obbligatoria una sua regolamentazione per poter raggiungere una tutela efficace dei diritti fondamentali. Bisogna affrontare con determinazione alcune sfide: una è la trasparenza e l’indipendenza nella gestione dei media. Sono necessari per via legislativa meccanismi in grado di ridurre al minimo i conflitti di interessi che minano la libertà editoriale. Se i media sono legati a soggetti politici o economici, il rischio di manipolazione è ampio: serve una normativa che aiuti la separazione fra proprietà, linee editoriali e finanziamenti, che protegga l’accesso imparziale alle risorse pubblicitarie e sostenga un sistema mediatico variegato, in cui anche le voci indipendenti possano esistere. L’altra sfida è quella di favorire una informazione di qualità che sappia andare al di là della cronaca urlata, la logica della eterna emergenza e la esibizione del dolore. Valorizzare la buona informazione significa sostenere il giornalismo di approfondimento, che verifica le fonti, che analizza i fenomeni, che dà voce alle soluzioni e non soltanto ai problemi. È indispensabile riequilibrare l’attenzione mediatica, spesso orientata a titoli sensazionalistici e a narrazioni disastrose, in favore di un approccio costruttivo, che non confuta i fatti ma li contestualizza, li decifra e aiuta i cittadini a capire la complessità: l’informazione può contribuire non solo a descrivere la realtà ma anche a migliorarla, offrendo strumenti conoscitivi e culturali per affrontare le sfide di questo tempo. La terza sfida è quella relativa all’educazione civica digitale. In un’era in cui i giovani si formano e si informano su piattaforme e social e usano l’IA, occorre fornire loro gli strumenti critici per distinguere fra informazione vera e contenuti falsi. Allora educare alla cittadinanza digitale significa insegnare a leggere e a comprendere le notizie, a riconoscere le fonti, a interrogarsi sui processi che conducono alla formazione dell’opinione pubblica; ma pure favorire un utilizzo responsabile delle tecnologie, un dialogo consapevole con i media tradizionali e un atteggiamento attivo nella costruzione dello spazio digitale pubblico. La libertà di stampa non è mai conquistata una volta e per tutte: è un bene fragile, che va difeso ogni giorno con scelte politiche, con l’impegno degli operatori dell’informazione e con la partecipazione dei cittadini.
VISITA IL MENÙ DEL GIUBILEO