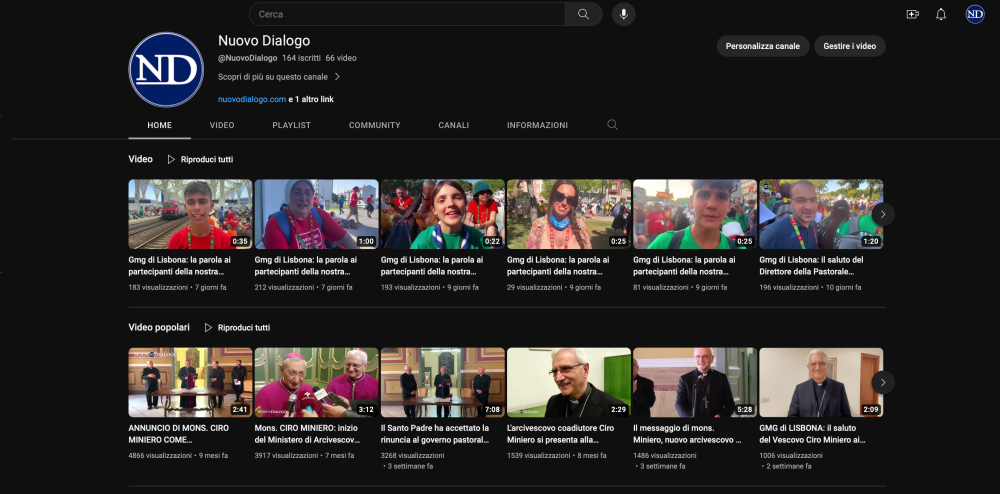Mai più Srebrenica? E Gaza?

Ogni anno l’11 luglio i corpi dei morti estratti dalle fosse comuni e identificati sono sepolti nel cimitero di Potocari, pochi chilometri a nord di Srebrenica. È una commemorazione importante, a cui partecipano i familiari delle persone uccise, insieme a tantissima altra gente. L’eccidio del luglio del ’95 – oltre ottomila musulmani bosniaci trucidati – non è una cicatrice: è una ferita aperta, è una lesione profonda, ancora adesso, dopo trenta anni, sanguinante. Ma che cosa era Srebrenica prima del massacro? Una sacca fuori controllo, ingrossata all’inverosimile da disperazione e resistenza, nelle spinose vicende della pulizia etnica lungo il fronte bosniaco. Un territorio isolato, un’area circondata, una enclave musulmana sacrificata perché fuori dalla logica di spartizione territoriale degli accordi di pace. Srebrenica fu abbandonata da tutti, proprio tutti, inclusa l’ONU, che nel 1993, con una risoluzione, aveva dichiarato “Srebrenica zona protetta”. Fu una pagina spaventosa della storia degli ultimi secoli perché la guerra in Bosnia ed Erzegovina ebbe il suo corso, anzi il suo sporco gioco, sugli aiuti umanitari: i serbo-bosniaci partirono con il favore delle armi, portando i musulmani sull’orlo della fame e manipolando gli aiuti allo scopo di fare, così, spostare la popolazione. La maggior parte degli assedi, Sarajevo compresa, mirava all’erogazione dell’acqua, al pane e al mercato nero. I protagonisti erano i cecchini – come dimenticare a questo proposito il tristemente famoso viale dei cecchini di Sarajevo – e i mortai. Proprio come oggi: ridurre alla fame e terrorizzare per poi trasferire in altro luogo. La sorte fu tragica per chi fuggì e per chi si illuse di poter essere protetto dall’ONU: in almeno tre occasioni le truppe serbe bombardarono la colonna in marcia, arrestarono migliaia di maschi fra i 16 e i 65 anni, i prigionieri furono detenuti in strutture provvisorie e poi liquidati. Alla base ONU di Potocari – poi diventata memoriale e cimitero per quei martiri – il generale olandese Thom Karremans, capo del contingente di caschi blu di protezione dell’enclave, fu costretto a negoziare l’evacuazione di civili da dentro e davanti la sua base con quel criminale di guerra di Ratko Mladic, ben determinato a umiliarlo con tanto di riprese televisive. Srebrenica è stata una tragedia per le Nazioni Unite, la cui credibilità è stata seriamente compromessa. È morta su quei monti l’idea che si possano allestire operazioni di mantenimento della pace là dove una pace da mantenere non c’è, sperando che i belligeranti rispettino le truppe dell’ONU semplicemente per le insegne che portano. Dopo ben ventinove anni, il 23 maggio del 2024, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato l’11 luglio Giornata Internazionale di Riflessione e Commemorazione del genocidio di Srebrenica del 1995. Trenta anni dopo, in Serbia, regna un clima tutt’altro che commemorativo: per la leadership serba tutte le parti coinvolte nel conflitto hanno commesso vari crimini, e tutti e nessuno sono responsabili. Una posizione vicina a quella sostenuta dopo la guerra da un altro criminale di guerra, l’ex presidente della Repubblica Slobodan Milosevic. E poi ci sono paesi che sostengono che non si debba parlare di singolo atto di genocidio e fra questi c’è Israele. La linea è ridurre l’accaduto alla nozione di crimini di guerra adoperando slealmente l’attenuante della separazione di donne e di minori, prima delle esecuzioni di massa. Forse l’unicità della Shoah non ammette pluralità oppure attacchi al primato: il timore è che la gravità del crimine ne risulti sminuita. O, forse, c’è il timore che la risonanza della violenza sui civili possa dare vigore a dei precedenti. La Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia e il Tribunale Penale Internazionale per la ex-Jugoslavia, hanno infatti chiamato genocidio un massacro che è stato attuato mentre la comunità internazionale era impegnata a intervenire nel più ampio contesto della guerra in Bosnia, vale a dire che ci può essere un genocidio in un luogo, all’ombra di un più ampio contesto bellico. Da mesi ormai il ministro della Difesa israeliano Israel Katz dichiara che gli abitanti di Gaza dovrebbero poter andarsene se lo desiderano e che il governo di Netanyahu è pronto a collaborare con gli Usa per trovare paesi disponibili a offrire ai palestinesi un avvenire, garantendo loro libertà di scelta. Si può definire scelta? Andarsene o morire di stenti in un grande campo di concentramento fra le macerie? Gli storici della nostra epoca sostengono che non si può guardare al Ventesimo secolo senza collocare la Shoah al centro del divenire storico: sicuro, ma è anche vero che va guardata la trasformazione radicale che tale memoria ha subito, diventando arma per sostenere – alle volte in modo sproporzionato e spesso in modo incondizionato – l’azione di Israele, quasi fosse una prova attitudinale per essere accolti fra le forze politiche sedicenti “democratiche e rispettabili” e per non finire nell’elenco delle “canaglie”. È chiaro che ci sono in gioco dei rapporti di forza e di dipendenza militare e anche tecnologica, in uno scenario mondiale che ripropone delle contrapposizioni per blocchi geopolitici. L’attacco in corso contro la relatrice dell’ONU, Francesca Albanese, può essere letto come il preannuncio di un mondo spudoratamente senza regole, senza norme, in cui alcuni stati rivendicando il diritto di commettere crimini senza doverne rendere conto, rispondere, spiegare, giustificare, motivare. E per di più non si sentono in alcun modo limitati. Il massacro di luglio del ’95 non rimase impunito: tredici imputati furono condannati a pene pesantissime. Sfuggì soltanto Milosevic, chiamato da Dio a ben altro giudizio. Da trenta anni, il mondo convive con questa ferita aperta, con questa lesione profonda, che non finisce mai di sanguinare, alimentata dalle “riflessioni” di un dibattito pubblico strumentale.